Alle persone che leggono Wikipedia interessa lo sport e la
musica, con una predilezione particolare per il Festival di
Sanremo. Ecco le tendenze che emergono chiaramente dall’analisi
delle voci più lette su Wikipedia in italiano nei primi sei mesi
del 2024. I volontari Smatteo499, Oltrepier, Cadiprati e
PapaYoung89 hanno infatti messo insieme i dati disponibili
pubblicamente mese per mese ed hanno elaborato la classifica,
arricchita di commenti e – siccome stiamo parlando pur sempre di
Wikipedia – di molti link alle fonti e ad altre voci.
1. Jannik Sinner – 3
213 757 visualizzazioni
Il tennista italiano sta vivendo forse l’anno più importante
della sua carriera, e lo dimostra il suo ruolo da “portabandiera”
di questo speciale, lo stesso che ha avuto nell’edizione
di esordio della nostra rubrica. Nei soli primi sei mesi di
quest’anno, Sinner ha vinto tre tornei, fra cui l’Australian
Open (il suo primo trofeo del Grande
Slam), diventando al contempo il
tennista italiano più vincente nella cosiddetta “Era Open”, ma
anche, e soprattutto, il nuovo
numero uno del ranking ATP. In questa veste, a giugno ha
affrontato l’Halle
Open, in cui si è aggiudicato il suo primo
torneo su erba, e
Wimbledon, in cui invece è stato eliminato ai quarti di finale,
dopo un
lungo incontro con Daniil
Medvedev.
È il club partenopeo a comparire sul secondo gradino del podio,
anche se in questo caso contano più i “demeriti” sportivi. La
squadra è reduce da
una stagione al di sotto delle aspettative, che ha visto
alternarsi sulla panchina tre diversi allenatori (Rudi Garcia,
Walter
Mazzarri e Francesco
Calzona),
nessuno dei quali è però riuscito ad arrestare una crisi di
risultati culminata nel 10° posto in campionato, e
nella
mancata qualificazione alle coppe
europee per la prima volta dopo 14 anni. Il Napoli ha quindi
restituito un’immagine
molto distante da quella data durante l’annata
precedente, conclusasi con la vittoria del terzo Scudetto. Il
rilancio della squadra è stato
affidato al tecnico Antonio Conte,
nominato lo scorso 5 giugno: riuscirà nel compito?
3. Facebook – 2 064 990
visualizzazioni
Una delle sfide più divertenti di questo primo semestre è stata
capire, di volta in volta, perché la piattaforma di Meta sia ormai
una presenza fissa delle nostre classifiche mensili, come provato
da questa “medaglia di bronzo”. In realtà, le motivazioni sono
molteplici: dai festeggiamenti per il
ventesimo anniversario (caduto lo scorso 4 febbraio), alle
controversie riguardanti la stessa Meta, fra cui il coinvolgimento
nelle
indagini della Commissione
Europea sulla concorrenza nel mercato digitale, e gli
scontri con la stampa australiana sulla promozione dei
contenuti giornalistici, che hanno portato alla
chiusura della sezione “news” di Facebook nel Paese, oltre che
in Canada.
Al quarto posto, troviamo la voce sul celebre cantante di
origini lucane, scomparso nel dicembre del 2014; come avvenuto
a febbraio, precede direttamente la figlia Angelina, vincitrice
dell’ultimo
Festival di Sanremo, da cui è stato
omaggiato durante la serata delle cover, con
un’interpretazione estremamente sentita del brano del 2002 La
rondine.
5. Angelina Mango –
1 745 889 visualizzazioni
Al quinto posto, dunque, c’è proprio la cantautrice figlia di
Mango e Laura
Valente, che nel corso di quest’anno ha tagliato numerosi
traguardi importanti della sua giovane carriera: non solo la
vittoria a Sanremo, con il brano La
noia, ma anche la partecipazione all’Eurovision
Song Contest a Malmö, che ha
concluso
al settimo posto. Inoltre, il 31 maggio scorso, l’artista
ha pubblicato il suo album d’esordio, Poké
melodrama.
Sesto posto per il surreale film del regista greco Yorgos
Lanthimos, adattamento dell’omonimo
romanzo di Alasdair Gray.
Presentato a
Venezia, dove ha vinto anche il Leone d’oro, nel
corso dell’anno il film è stato premiato con quattro Oscar e due
Golden
Globe. Tra gli attori principali figurano Emma Stone, protagonista
della storia, Mark
Ruffalo, Willem
Dafoe, Ramy
Youssef e Jerrod
Carmichael.
In settima posizione, troviamo la 17^ edizione degli Europei
di calcio, che per la terza volta nella sua storia è
organizzata dalla Germania, dopo quelle
del 1988,
un anno prima della riunificazione
delle repubbliche occidentale e
orientale,
e del 2020,
in cui però il Paese era solo una delle tappe itineranti. Il torneo
è iniziato il 14 giugno e ha visto sia percorsi in un certo modo
sorprendenti, come quelli di Georgia,
Turchia
e Svizzera,
ma anche eliminazioni più o meno clamorose, fra cui quelle di
Belgio,
Ucraina
(estromessa solo per via della
differenza reti) e anche dell’Italia,
eliminata
negli ottavi proprio dalla Svizzera. In finale, però, si
affronteranno la Spagna,
già detentrice di tre titoli, e l’Inghilterra,
ancora una volta
alla ricerca del suo primo, storico successo.
La cantante italiana si posiziona all’ottavo posto, forte del
podio ottenuto al Festival
di Sanremo di febbraio con il brano Sinceramente,
certificato triplo platino, e che in seguito l’ha condotta fino
al
terzo posto nella classifica
FIMI dei singoli più venduti del primo semestre del 2024. Come
se non bastasse, a giugno, l’Unione
Astornomica Internazionale ha
dedicato un asteroide all’artista ligure, su proposta
dell’astronomo amatoriale ed ingegnere Antonino Brosio.
9. Ghali (rapper) –
1 291 889 visualizzazioni
A seguire, un altro artista in gara a Sanremo: il rapper,
classificatosi quarto con la canzone Casa
mia, ha attirato l’attenzione anche per le sue
dichiarazioni sul palco del Festival, dove chiese lo “stop al
genocidio”, riferendosi alla guerra ancora in
corso nella Striscia di Gaza, e alle sue conseguenze sui civili
palestinesi. Tra
maggio e giugno, l’artista ha ottenuto anche un altro
disco di platino grazie al singolo estivo Paprika,
ispirato al genere
Afrobeats.
Il decimo posto è occupato proprio dalla settantaquattresima
edizione del Festival della canzone italiana, vinta dalla
sopracitata Angelina Mango. Altri artisti classificatisi nelle
prime posizioni sono stati Geolier, Annalisa,
Irama e Mahmood. Svoltosi lo
scorso febbraio, il Festival ha ottenuto una media del 65,44% di
share,
con la sola serata finale che è stata vista in media da
14 milioni e 301 mila spettatori.
11. Gigi Riva – 1 093 718
visualizzazioni
L’ex calciatore italiano è
deceduto lo scorso gennaio, a 79 anni. Leggenda del Cagliari, in
cui ha militato per la maggior parte della sua carriera, nonché
membro della Hall
of Fame del calcio italiano, Riva è tuttora
capocannoniere della nazionale italiana, con la quale ha vinto
gli Europei
del 1968 (segnando anche una delle due reti del successo nella
ripetizione della finale contro la
Jugoslavia), per poi arrivare in
finale ai Mondiali
del 1970.
12. Carlo Ancelotti
– 1 002 106 visualizzazioni
Dodicesimo posto per l’allenatore italiano, dovuto in gran parte
alla
vittoria della Champions
League con il suo Real
Madrid, in seguito al successo per 2-0 in
finale sul
Borussia Dortmund. Si tratta del successo numero 15 nella
competizione per il club spagnolo, mentre per il suo allenatore è
il sesto. Inoltre, in questa
stagione Ancelotti ha guidato i Blancos anche
alla conquista
della Supercoppa
spagnola. Infine, quest’anno il tecnico ha superato le 250
presenze in panchina con il club madridista
e le 200 in Champions League (diventando il primo a
riuscirci).
13. Rocco Siffredi –
996 647 visualizzazioni
Il noto regista e attore pornografico italiano ha conquistato il
primo posto nella nostra classifica
a marzo, probabilmente principalmente a causa della serie di
Netflix Supersex
(basata sulla sua vita), ma anche alla vicenda che lo ha visto
essere denunciato da una giornalista per molestie sessuali.
Inizialmente Siffredi ha respinto le accuse, ma successivamente
si è scusato di persona con la giornalista.
14. Mare fuori –
985 649 visualizzazioni
La fortunata serie ideata da Cristiana Farina, ambientata in un
immaginario istituto penale
per minorenni di Napoli, è stata una
delle due sole voci in grado di spezzare il “monopolio” di Sanremo
nella nostra classifica di
febbraio, pur
usufruendo comunque dell’enorme cassa di risonanza del
Festival. Merito del successo della sua
quarta stagione, inizialmente resa disponibile
su RaiPlay,
prima di essere trasmessa in chiaro su Rai 2 dal 14 febbraio al
27 marzo.
Quindicesima posizione per il club nerazzurro, che il 22 aprile
di quest’anno ha conquistato il 20° scudetto della sua storia, e
quindi la seconda stella. La vittoria del campionato di Serie A,
arrivata proprio nel derby contro i rivali del Milan,
è il culmine di una stagione
quasi perfetta da parte della squadra guidata da Simone Inzaghi,
che ha conquistato anche la Supercoppa
italiana.
16. Chico Forti – 975
626 visualizzazioni
Sedicesima in classifica la voce su Chico Forti, protagonista di
un caso controverso e divisivo, per cui era detenuto in Florida dal 2000.
Già campione di windsurf e fondatore
di una casa di produzione di filmati di sport estremi, la
sua figura salì alla ribalta nel 1998, quando venne condannato
all’ergastolo
per l’omicidio
di Dale Pike, figlio dell’imprenditore Anthony Pike. Dopo
l’interessamento di vari
ministri degli esteri italiani e una lunga trattativa
diplomatica fra il nostro Paese e gli Stati Uniti, il 1º marzo
2024 la
Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
ha annunciato ufficialmente
il rientro di Forti in Italia. Quindi, lo scorso 18 maggio,
l’ex velista è stato
trasferito al carcere Montorio di Verona.
Diciassettesima posizione per il gravissimo incidente
aereo che coinvolse il volo charter 571
delle Forze
Aeree Uruguaiane, partito da Montevideo il
13 ottobre 1972 e inizialmente diretto a Santiago del
Cile, ma poi precipitato sulla Cordigliera delle
Ande con 45 persone a bordo. Nei mesi successivi allo
schianto, i 16 sopravvissuti (molti dei quali appartenenti alla
squadra di rugby dell’Old Christians
Club) dovettero affrontare il gelo, la fame e
una valanga, ricorrendo
persino al cannibalismo per
sopravvivere. Solo 14 superstiti rimasti sul posto furono tratti in
salvo nel dicembre dello stesso anno. Da questi eventi è stato
tratto il film del 2023 La
società della neve, remake di Alive –
Sopravvissuti (1993) e I
sopravvissuti delle Ande (1976),
selezionato per rappresentare la Spagna nella categoria
Miglior film internazionale ai premi Oscar
2024.
Si classifica diciottesimo il film biografico scritto e diretto
da Christopher
Nolan, tratto dalla biografia Robert
Oppenheimer, il padre della bomba
atomica (di Kai
Bird e Martin J.
Sherwin) e basato sulla vita del fisico teorico
statunitense J. Robert
Oppenheimer, conosciuto principalmente come direttore
del progetto
Manhattan durante la Seconda
guerra mondiale. Il film ha trionfato agli ultimi Premi Oscar,
conquistando ben sette statuette: oltre a quelle per il Miglior
film e il Miglior
regista, anche quelle di Miglior
attore protagonista (a Cillian Murphy)
e
non protagonista (a Robert Downey
Jr), Miglior
montaggio, Miglior
fotografia e
Miglior colonna sonora originale.
19. Mahmood – 847
680 visualizzazioni
Diciannovesima posizione per Alessandro Mahmoud, in arte
Mahmood, già vincitore di due edizioni del Festival
di Sanremo nel 2019 e
nel 2022.
Quest’anno, l’artista ha partecipato per la terza volta alla
kermesse con
la canzone Tuta
gold, con cui si è piazzato al sesto posto in
classifica generale e ha conquistato la vetta della
classifica Top Singoli
(redatta dalla FIMI), mantenuta per tre
settimane, oltre a ben 4
dischi di platino. Il brano ha anche anticipato il terzo album
dell’artista, Nei letti
degli altri, contenente anche il nuovo singolo ora
in rotazione radiofonica, Ra ta ta.
A concludere questa classifica speciale è la voce sul cantautore
e attore romano (ma nato in Libia), scomparso nel
2013; lo scorso 11 febbraio, è stato trasmesso in prima serata
su Rai 1 il
film Califano,
diretto da Alessandro
Angelini e tratto dal libro Senza manette,
scritto a quattro mani dallo stesso artista con Pierluigi
Diaco. Nel film televisivo, in cui il cantante è
interpretato da Leo Gassmann,
vengono raccontate la vita e la carriera del “Califfo”, dagli
esordi fino al 1986, passando per il
caso giudiziario che lo coinvolse direttamente
nel 1984.
Immagine:
Wikipedia mini globe handheld, di Wikimedia Foundation,
CC BY-SA
3.0, da Wikimedia Commons
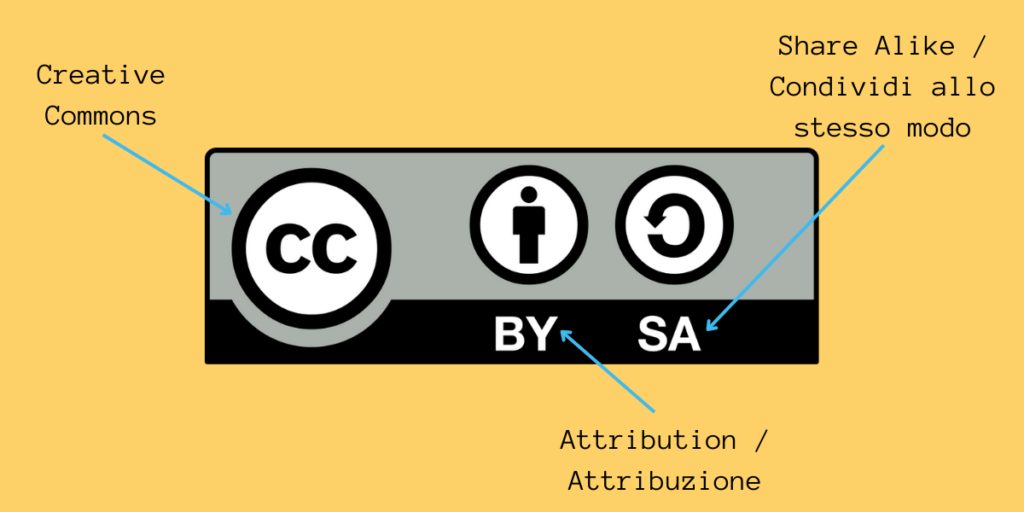
 Per la quarta volta la Wikimedia Foundation
Per la quarta volta la Wikimedia Foundation  Mi ero perso
Mi ero perso 
 Piergiovanna Grossi è un’attiva wikipediana. Ma è anche
una professoressa a contratto e una ricercatrice, e le è capitato
di scrivere un articolo per una
Piergiovanna Grossi è un’attiva wikipediana. Ma è anche
una professoressa a contratto e una ricercatrice, e le è capitato
di scrivere un articolo per una  Siamo in estate, non che molto da dire, e così
Siamo in estate, non che molto da dire, e così
 Aggiornamento: (12:15) E invece no,
Aggiornamento: (12:15) E invece no, 


 Emily St. John Mandel è una scrittrice canadese nota
per i suoi libri Stazione Undici (credo che ne abbiano fatto
anche una serie tv, ma è un campo in cui non mi addentro) e Mare
della tranquillità. Qualche giorno fa
Emily St. John Mandel è una scrittrice canadese nota
per i suoi libri Stazione Undici (credo che ne abbiano fatto
anche una serie tv, ma è un campo in cui non mi addentro) e Mare
della tranquillità. Qualche giorno fa 
 Su Valigia Blu, Bruno Saetta
Su Valigia Blu, Bruno Saetta 

 Per il raggiungimento di questo risultato mi preme
ringraziare i miei fidi beta tester anticipati Yacine Boussoufa e
Stupeficium, ma anche il carissimo sviluppatore Titanium Michael
Gangolf, che mi ha dato alcuni importanti consigli per
l’applicazione
Per il raggiungimento di questo risultato mi preme
ringraziare i miei fidi beta tester anticipati Yacine Boussoufa e
Stupeficium, ma anche il carissimo sviluppatore Titanium Michael
Gangolf, che mi ha dato alcuni importanti consigli per
l’applicazione